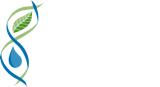Recuperare, conservare e valorizzare vitigni ormai rari e “dimenticati”, significa salvaguardare quella parte di preziosa diversità genetica ancora esistente e soprattutto identitaria di un territorio e delle persone che lo abitano. In questo quadro, il contributo della ricerca, in particolare quella del CREA Viticoltura ed Enologia, è determinante. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei vitigni recuperati d’Italia dal Lazio con Rosciola, l’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura greca e quella etrusca.
Il concetto di biodiversità è ormai diventato di uso comune, anche in viticoltura, sebbene ancora molti non abbiano esattamente presente che la diversità biologica è un valore da custodire, salvaguardare e sviluppare, perché fortemente a rischio di erosione genetica. A conferma di ciò, si tenga conto che l’agricoltura, che utilizzava migliaia di specie vegetali per il sostentamento di pochi milioni d’uomini, si è trasformata nel volgere di qualche secolo in una tecnica evoluta, che nutre con poco più di 150 specie qualche miliardo di persone. Se guardiamo alla viticoltura, le cose non vanno meglio.
La viticoltura in Italia
L’Italia è il Paese con maggior biodiversità viticola al mondo. Possiede un patrimonio viticolo con circa 1583 varietà tradizionali originarie (Andersen e Nelgen, 2020). Di queste, poco più di 600 sono quelle iscritte al Registro Nazionale delle Uve da Vino, ovvero quelle autorizzate alla coltivazione e alla produzione di vino. La Francia, nostro storico competitor in campo enologico e attualmente principale produttore di uva da vino, ne possiede circa la metà.
In questo scenario, recuperare, conservare e valorizzare vitigni ormai rari e, “dimenticati”, significa salvaguardare quella parte di preziosa diversità genetica ancora esistente e che è soprattutto identitaria di un territorio e delle persone che lo abitano.
Il vitigno Rosciola

Questo studio di ricerca ha preso in esame il vitigno Rosciola, una varietà quasi del tutto scomparsa, originaria del comune di Subiaco, in provincia di Roma. Questo piccolo paese, quest’anno insignito del titolo di “capitale della cultura”, deve la sua notorietà alla presenza del monastero di San Benedetto, fondato dall’omonimo monaco e santo, che impose ai suoi seguaci la famosa Regola, sintetizzata dalle parole “ora et labora” (prega e lavora). Ciò si tradusse nell’attività primaria dei monaci di affiancare alla preghiera e alla meditazione anche quella del lavoro manuale ed in particolare quello della copiatura di manoscritti antichi, specie di quelli biblici.
Il nome Rosciola è di origine dialettale ed è probabilmente dovuto alla colorazione rosso pallido che assumono gli acini a maturazione (Figura 1).
L’areale di coltivazione è situato tra i Monti Simbruini e l’alta valle dell’Aniene, nel comune di Subiaco e nei comuni circostanti di Cervara ed in misura ridotta di Olevano Romano, territorio già descritto da Mancini (1888) nel libro “Lazio viticolo e vinicolo”. Per la sua posizione geografica, il Lazio, ed in particolare questo territorio, rappresentò l’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura greca e quella etrusca.

Il recupero
Il lavoro di ricerca svolto ha avuto come obiettivo quello di preservare dall’abbandono di questa varietà “dimenticata” e allo stesso tempo trovare un possibile utilizzo enologico per valorizzare il vino anche in termini commerciali, facendo leva sull’unicità e sull’identità territoriale della produzione. Per far questo è stata pianificata una serie di interventi. In primo luogo, si è avviata la ricerca delle poche viti rimaste sul territorio di Rosciola, su cui – una volta trovate – sono stati eseguiti prelievi di organi vegetali (germoglio, foglia etc.) per eseguire delle analisi genetiche in modo tale da essere certi di lavorare su materiale certificato originale.
Contestualmente, si è eseguita una descrizione ampelografica della cultivar (fig. 2) per studiare la composizione chimica e analitica dell’uva. Sulla base delle indicazioni raccolte, si è poi proceduto alla raccolta e alla vinificazione per valutare la composizione chimica del vino.

Alla luce dei risultati conseguiti e, tenendo presente le caratteristiche chimiche e sensoriali dei vini ottenuti, si è poi passati ad esaminare quale fosse l’attitudine enologica più corretta per questa varietà. Avendo ottenuto dei vini che presentavano una scarsa dotazione fenolica, ovvero una bassa presenza di antociani (responsabili del colore rosso del vino) e, al tempo stesso, dotati di una buona composizione in acidi organici, l’orientamento è stato quello di pensare alla produzione di un vino spumante rosé, tenendo anche presente l’aspetto commerciale e la ricaduta in termini economici che il prodotto avesse potuto avere.
I risultati ottenuti
I risultati sono stati davvero incoraggianti e sono di seguito sintetizzati:
- il vitigno Rosciola è caratterizzato da notevole rusticità, presenta un germogliamento tardivo, che gli permette di superare senza danni gelate e brinate primaverili, ed ha una normale resistenza alle principali malattie fungine.
- I vini sono caratterizzati da colore rosa con leggera tendenza all’arancio. Si presta sia alla produzione di vini fermi e tranquilli ma anche, come nella nostra sperimentazione, a vini frizzanti e spumanti.
- L’analisi sensoriale un aspetto visivo brillante e perlage fine e persistente. All’olfatto si esaltano le note fiorali e fruttate, così come i sentori che richiamano il pane tostato e lievito, che contribuiscono a dare complessità al vino. Al gusto la freschezza, accentuata da sensazioni saline date dalle note minerali, conferisce al prodotto una particolare unicità.
Facendo seguito a quanto detto, considerando l’importanza turistica della zona (Monastero di San Benedetto, Subiaco – Capitale della Cultura 2025, Parco Regionale dei Monti Simbruini ecc..) ci auguriamo che il lavoro svolto possa costituire un valido volano per la commercializzazione dei prodotti ottenibili da questo vitigno, che racchiude in sé l’espressione della storia, della cultura e delle tradizioni proprie del territorio, contribuendo al tempo stesso alla salvaguardia delle biodiversità ivi presenti, nonché alla tutela dell’ambiente.

Collaboratore Tecnico CREA Centro Viticoltura ed Enologia
#lafrase Il vino è la prova che Dio ci ama e che vuole vederci felici (Benjamin Franklin)

Collaboratore Tecnico CREA Centro Viticoltura ed Enologia
Enologo laureato ha sviluppato negli anni un’articolata competenza in materia di vini speciali, passiti e spumanti elaborati sull’intero territorio nazionale, con specifiche esperienze di ricerca e sviluppo con le aziende del settore nella formulazione di protocolli innovativi
#lafrase Osservare oltre le apparenze