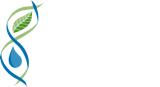Viticoltura e trasformazione enologica di uva da tavola e da vino, ma anche conservazione e valorizzazione del germoplasma viticolo nazionale. E ancora studi chimici, biologici e sensoriali, con lo sguardo puntato a biodiversità, sostenibilità e innovazione. 4 sedi (Conegliano, Asti, Velletri e Turi) e 100 anni di storia al servizio del vino italiano: è il CREA Viticoltura ed Enologia
Utilizzare la propria expertise per rendere il vino italiano sempre più competitivo sui mercati, coniugando quella qualità – che è ormai un nostro tratto distintivo – con la sostenibilità e la resilienza ai cambiamenti climatici. Questa la mission del CREA Viticoltura ed Enologia, che lavora a supporto del comparto vinicolo italiano, eccellenza del made in Italy.
Il Centro di Viticoltura ed Enologia, che nel 2022 e nel 2023 ha festeggiato il centenario delle sedi di Asti e di Conegliano, realizza piani di selezione varietale della vite, esegue analisi di caratterizzazione genetica e qualitativa delle cultivar nazionali e internazionali e dei relativi cloni, con metodi convenzionali e biologico-molecolari. Svolge studi sulle tecniche di conservazione, di propagazione, di coltivazione e di protezione fitosanitaria della vite, approfondendo specialmente le interazioni tra metodi di produzione e qualità dell’uva e del vino.
Dispone di laboratori attrezzati per la coltura “in vitro” e il risanamento della vite. Il miglioramento genetico, finalizzato alla creazione di nuove varietà di uva da tavola e da vino, si concentra prevalentemente sull’ottenimento di cultivar resistenti e sull’esplorazione della biodiversità occulta presente nel genoma della vite, non ancora pienamente espressa.
Il Centro si occupa del recupero e della caratterizzazione dell’intero germoplasma nazionale, con particolare riguardo alle varietà autoctone e internazionali.
Le innovazioni scientifiche del CREA Centro Viticoltura ed Enologia
Miglioramento genetico: tra i più importanti settori in cui il Centro primeggia, è nato praticamente da zero o poco più, ma è cresciuto in maniera esponenziale: basti dire che dispone del più grande (dimensionalmente) piano di miglioramento genetico in Italia, probabilmente in Europa. Da Nord a Sud, oltre 20.000 genotipi sono in corso di valutazione per resistenze alle maggiori malattie fungine e per la qualità degli incroci tra varietà autoctone (Glera, Sangiovese, Primitivo, Cesanese per fare degli esempi molto conosciuti) e vitigni resistenti di ultima generazione.
Biotecnologie applicate alla vite: altro settore di grande interesse, in particolare quelle finalizzate all’ottenimento di portainnesti resistenti allo stress idrico e di vitigni resilienti alle maggiori malattie fungine, allo scopo di ottenere piante che richiedano minori trattamenti e superino situazioni di stress idrico. Vari esperimenti di tecniche di evoluzione assistita (TEA) e cisgenesi hanno prodotto piantine in vitro pronte per i primi test in campo, non appena saranno stabiliti i criteri e individuate le località ideali in accordo con le regioni interessate.
Viticoltura digitale: Le più avanzate applicazioni tecnologiche, dalle apparecchiature meteo e software predittivi, alla sensoristica prossimale (nel terreno o sulla pianta) e distale (droni e satelliti) sono in corso di sperimentazione in numerosi progetti con aziende di medio-grandi dimensioni e consorzi di rilevanza nazionale.
Fitoplasmosi e controllo alternativo dei maggiori patogeni: Nel Centro esiste uno dei gruppi più competenti nella lotta alle fitoplasmosi della vite, flavescenza dorata e legno nero, che flagellano tutt’oggi il Nord Italia. Il CREA VE è parte integrante della task force istituita dal Ministero per controllare la malattia e trovare soluzioni praticabili ed ecocompatibili. Con pari intensità, si lavora da tempo anche nella gestione sostenibile del vigneto con la regione Veneto, sia per contenere l’uso del rame e dello zolfo entro i parametri richiesti, che per limitare l’uso dei pesticidi riducendolo ai minimi termini. E’ stata, poi, realizzata la più grande banca dati dei microrganismi del terreno ed epifiti (conviventi sulla pianta) potenziali protettori dai patogeni fungini (mal dell’esca).
Metabolomica della vite: Le capacità di analisi chimiche dettagliate, soprattutto di una visione olistica (in contemporanea di tutti i metaboliti) dei componenti di un prodotto, come ad esempio l’acino della vite ed il vino, rendono i contenuti scomponibili nei dettagli e fruibili grazie alle strumentazioni disponibili presso il Centro. Tutto ciò può garantire un supporto fondamentale nelle analisi dei prodotti delle nuove varietà resistenti, ma anche per le collaborazioni con la Repressione Frodi (ICQRF), con cui si lavora per prevenire l’entrata in commercio di varietà caratterizzanti il territorio, come il Pinot Grigio delle Venezie o il Primitivo di Puglia, contaminate da prodotti non consoni alla qualità e purezza del prodotto.
Certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite: Il Centro è anche titolare della gestione e dell’aggiornamento del Catalogo Nazionale delle Varietà di vite, che, come “campo Catalogo” è localizzato a Susegana e viene continuamente aggiornato. Relativamente alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, si sta predisponendo un catalogo nazionale informatico da rendere disponibile in rete.
Eco-fisiologia e agronomia: I gruppi di lavoro dedicati eseguono ricerche sulle tecniche colturali per favorire il corretto impiego e sfruttamento dell’energia radiante e delle risorse nutrizionali (acqua ed elementi fertilizzanti), per la valorizzazione delle sostanze elaborate, destinate a qualificare le produzioni vitivinicole. Particolare attenzione viene data al rapporto pianta-ambiente, che si concretizza in lavori di zonazione (sviluppati in tutto il territorio nazionale), di interazione suolo/qualità (con analisi degli apparati radicali), di valutazione delle espressioni qualitative più eccellenti (cru) e del rapporto clima/qualità. Riguardo quest’ultimo punto, si stanno sviluppando esperienze sul cambiamento climatico e sulla sua relazione con la tipicità aromatica delle uve e dei vini. La valutazione ambientale prende in considerazione anche il paesaggio e i suoi riflessi sulla qualità percepita dei vini.
Chimica enologica: I laboratori operano nello studio dei composti dell’uva e del vino – caratterizzati da importanti proprietà nutraceutiche, antiossidanti e organolettiche (in particolare polifenoli, antociani, composti aromatici) – e dei composti legati al metabolismo e allo stato sanitario della vite (quali fitoalessine, metaboliti primari, proteine e tossine). L’attività si focalizza principalmente nello studio della chimica di uve e prodotti fermentati, anche attraverso lo sviluppo di nuovi metodi analitici basati, su tecniche di spettrometria di massa.
Microbiologia enologica: I laboratori forniscono contributi di rilievo riguardo la valorizzazione della biodiversità dei microrganismi di interesse enologico, il controllo di contaminanti micotici sulle uve e sulle origini della presenza di ammine biogene nei vini. Vengono effettuate analisi di microbiologia classica e caratterizzazione biomolecolare dei microorganismi di interesse enologico. Oltre all’attività di ricerca, si svolgono attività per le cantine che vanno dall’isolamento di lieviti autoctoni alle consulenze per l’identificazione di contaminanti, tra i quali Brettanomyces. Il Centro dispone di una collezione di microorganismi costituita da 1500 lieviti e 280 batteri.
Analisi sensoriale: L’attività di ricerca è rivolta alla valorizzazione di vitigni autoctoni, con la definizione del profilo sensoriale dei vini, individuando i descrittori visivi, olfattivi e gustativi che li caratterizzano. L’analisi sensoriale collabora con altri gruppi di ricerca per valutazione, attraverso opportuni test, di vini sperimentali realizzati nell’ambito di progetti di argomento microbiologico, tecnologico, chimico e viticolo. Le valutazioni riguardano prevalentemente il vino, ma anche le uve e altre bevande come succhi a base di uva, grappa, amari e birra. Il laboratorio fornisce servizi a soggetti pubblici e privati, rivolti anche a rilevare di eventuali difetti sensoriali nei vini. Si organizzano seminari e corsi di analisi sensoriale per scuole, enti pubblici e privati. Il laboratorio di Asti ha collaborato al progetto nazionale IT-TASTE (https://www.it-taste.it)
La storia Nel 1923, nacque a Conegliano la Stazione Sperimentale di Viticoltura, Ente Consortile autonomo costituito presso la Scuola Enologica per sostenere la viticoltura locale. Nel 1930 venne ufficializzata come Regia Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia. Nel 1933 venne posta la prima pietra della attuale sede di Conegliano e fra i primi interventi ci furono l’impianto sia di una collezione ampelografica – che comprendeva centinaia di vitigni da vino, da tavola, portinnesti e Ibridi Produttori Diretti (IPD), poi ampliata nel tempo – sia di numerosi vigneti sperimentali, preziosi per la ricostituzione viticola del Veneto e delle regioni limitrofe.
Nel 1967, divenne uno degli Istituti Sperimentali del Ministero dell’Agricoltura, con il nome di Istituto Sperimentale per la viticoltura, di pari grado degli Istituti scientifici universitari, articolato in 3 sezioni operative (Asti, Arezzo e Bari) che facevano riferimento alla sede centrale di Conegliano. Intanto, l’Istituto veniva investito di nuovi compiti: il Servizio Repressione frodi fino al 1986, il rilascio dei certificati di analisi per il vino destinato all’esportazione fino al 1995, il controllo della produzione ed il commercio dei materiali di propagazione della vite (Servizio Controllo Vivai).
Nel 1981 venne creata e messa a disposizione dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, una collezione di oltre 600 vecchi vitigni (in collaborazione con il CNR e diverse università italiane). Nel 2005 l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura confluiva nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), divenendo dal 2015 Centro per la Ricerca in Viticoltura (CRA-VIT). Nel 2017, con l’ultima riforma, il Centro acquisiva anche la ricerca in enologia e le diverse sezioni operative periferiche (Asti, Arezzo, Velletri, Turi e Gorizia) assumendo il nome di Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE).

Giornalista pubblicista e componente dell’Ufficio Stampa CREA
Svolge attività di branding, media relations, implementazione ed aggiornamento contenuti dell’area stampa del sito CREA, pianificazione eventi, rassegna stampa press e audio-video; news e comunicati stampa su seminari, convegni, eventi, studi e attività scientifiche dell’ente.