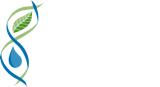Due nomi che indicano lo stesso cereale
Nel mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione, esistono parole che sembrano evocare prodotti diversi, ma che in realtà raccontano la stessa storia. È il caso di grano e frumento, due termini spesso usati come se fossero distinti, ma che in realtà indicano la stessa pianta del genere Triticum, uno dei cereali più coltivati e consumati al mondo.
Una distinzione solo apparente
Dal punto di vista botanico e agronomico, il nome corretto è frumento. Questo è il termine utilizzato nei testi scientifici, nei documenti ufficiali e nelle normative europee. Deriva dal latino “frumentum”, che significava genericamente “cereale”, ma nel tempo si è specializzato a indicare proprio il grano.
Il termine grano, invece, ha radici ancora più profonde nella lingua parlata. È il nome più popolare, quello che si è tramandato nei dialetti, nelle tradizioni contadine e nelle espressioni quotidiane. Parlare di “campi di grano” o di “pane di grano duro” è perfettamente naturale per la maggior parte delle persone.
In sostanza, si tratta di una differenza linguistica, non sostanziale. Grano e frumento sono la stessa cosa, ma il contesto ne determina l’uso. Quando si parla di grano o di frumento, si parla dello stesso cereale, base della nostra alimentazione e simbolo della civiltà agricola. La scelta del termine è solo una questione di contesto: più tecnico in un caso, più popolare nell’altro.
Le due anime del frumento: tenero e duro
A fare davvero la differenza non è il nome, ma la tipologia di frumento. Le due varietà principali del genere Triticum coltivate in Italia e nel mondo sono:
- Frumento tenero (Triticum aestivum) – Il chicco di questa specie presenta una consistenza friabile e farinosa, che si presta bene alla produzione delle cosiddette farine bianche (tipi 00, 0, 1, 2 e integrale). Le proteine di riserva contenute nelle cariossidi danno origine, durante l’impasto, a un glutine poco tenace e meno elastico rispetto a quello del frumento duro.
Per queste caratteristiche, le farine di frumento tenero risultano particolarmente adatte alla preparazione di prodotti da forno come pane a lievitazione moderata, dolci, biscotti e altri impasti che non richiedono una struttura proteica particolarmente resistente.
- Frumento duro (Triticum durum) – Il chicco di questa specie si presenta con una consistenza dura, compatta e vitrea, dovuta alla struttura più solida dell’endosperma e all’elevato contenuto di proteine e carotenoidi. Le proteine di riserva, in particolare le glutenine, generano un glutine più tenace e resistente, capace di mantenere la coesione e l’elasticità dell’impasto anche in assenza di lievitazione. Dalla molitura, si ottiene la semola, con caratteristiche ben diverse dalla farina bianca. La semola risulta ideale per la produzione di pasta secca di alta qualità, perché garantisce una tenuta eccellente in cottura, una consistenza al dente e un aspetto giallo dorato tipico della tradizione italiana. Per queste sue caratteristiche, il frumento duro rappresenta la materia prima quasi esclusiva per la produzione di pasta secca, sia a livello industriale che artigianale, soprattutto in Italia, dove l’utilizzo della semola di grano duro è previsto anche dalla normativa nazionale. Inoltre, trova largo impiego nella produzione del cous cous e nella preparazione di specialità da forno tipiche del Sud Italia, come il celebre pane di Altamura e altri pani tradizionali locali, spesso tutelati come prodotti tipici.

Biologa presso il CREA-CI, Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Acireale.
L’ attività scientifica condotta al CREA, a partire dall’ex Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Catania, ha portato a importanti risultati nel campo della ricerca applicata sul frumento. Le sperimentazioni condotte in questi anni si sono concentrate sulla caratterizzazione qualitativa e biochimica dei genotipi di Triticum, contribuendo a innovare le tecniche di analisi genetica delle varietà coltivate. Elemento distintivo di questa attività è l’uso dei marcatori biochimici delle proteine di riserva delle cariossidi, per la definizione del cosiddetto “fingerprinting” genetico. Uno dei risultati più significativi è lo sviluppo di un protocollo specifico per l’elettroforesi capillare delle proteine in SDS-PAGE, una tecnica avanzata che consente un’analisi più precisa e riproducibile delle componenti proteiche.
#lafrase “La scienza è una strada fatta di rigore e passione, dove la curiosità non conosce età e la determinazione può illuminare il futuro dell’umanità, proprio come ci ha insegnato Rita Levi Montalcini.”