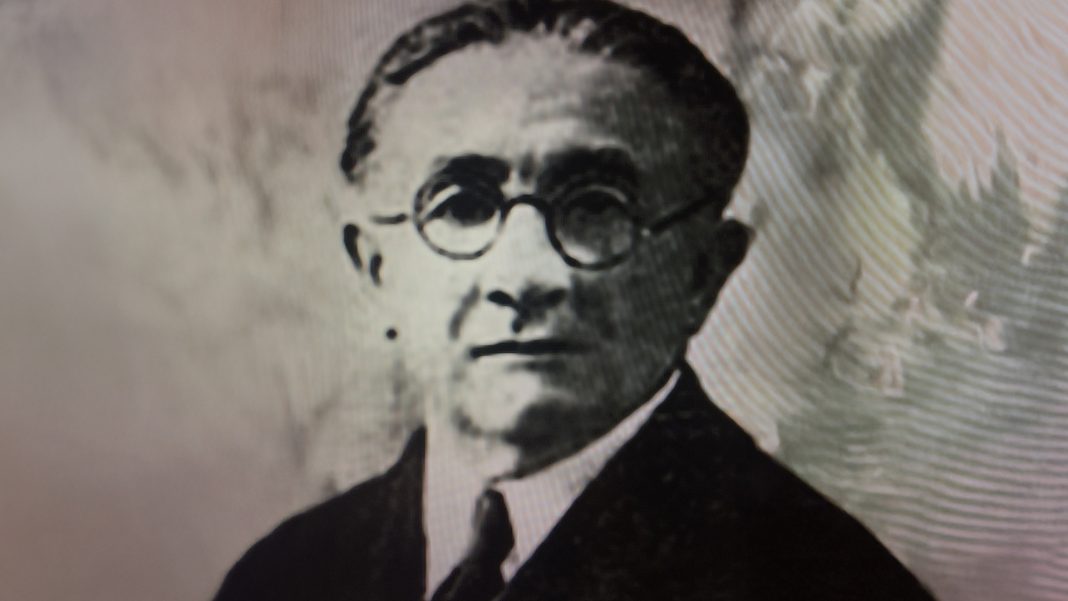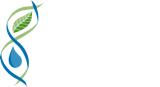Ottavio Munerati trasformò la coltivazione della barbabietola da zucchero da semplice pratica agricola a pilastro dell’industria nazionale. Fu quasi per caso che si imbatté nella barbabietola da zucchero, ma da lì rivoluzionò l’intero settore agroindustriale. Visionario e geniale, introdusse tecniche di selezione genetica ancora oggi adottate e scoprì varietà resistenti a malattie devastanti come la cercospora. Grazie a lui, la bieticoltura si diffuse anche nel Sud Italia e l’Italia divenne produttrice del proprio seme, abbattendo costi e dipendenze estere. In patria fu spesso sottovalutato, ma gli Stati Uniti gli resero onore costruendo un centro di ricerca a Rovigo. A distanza di un secolo, la bieticoltura internazionale segue ancora le sue orme.
La coltivazione della barbabietola da zucchero destinata alla produzione industriale ebbe inizio alla fine dell’Ottocento a Rieti (1875), con l’obiettivo di garantire una disponibilità nazionale di zucchero su cui applicare accise, fondamentali per il sostentamento del neonato Stato italiano. Il primo nucleo di zuccherifici industriali sorse tuttavia nella Pianura Padana, area particolarmente adatta alla coltivazione di questa specie.
Ottavio Munerati (1875-1949) si avvicinò quasi per caso alla barbabietola da zucchero, che divenne il fulcro della sua carriera. Dopo la laurea all’Università di Portici e un’esperienza giornalistica, entrò nella Cattedra Ambulante di Rovigo, dove, a soli 25 anni, ebbe il primo contatto con la bieticoltura. La rapida diffusione della coltura richiedeva adattamenti sia agronomici sia genetici. Nel 1908, Munerati pubblicò un manuale di riferimento per la coltivazione della barbabietola, e nel 1911 fu incaricato di strutturare la Regia Stazione di Bieticoltura a Rovigo, oggi CREA Cerealicoltura e Colture Industriali. Nel 1920 pubblicò la sua opera più importante: Osservazioni e ricerche sulla barbabietola da zucchero.
Contributi alla genetica e alla selezione
La sua opera ha avuto importanti ricadute pratiche. Analizzò a fondo le tecniche di selezione e fu tra i primi a promuovere la selezione “full-sib”, ancora oggi utilizzata. Fin dal 1905 studiò il fenomeno della prefioritura, identificando nella complessa interazione tra genetica, clima e tecniche agronomiche la causa del fenomeno. Riuscì a selezionare linee resistenti e dimostrò che, in certe condizioni, era possibile seminare in autunno. Questo fu fondamentale per la diffusione della bieticoltura nel Sud Italia. Munerati investigò anche la selezione di glomeruli monogermi, per ridurre il lavoro manuale di diradamento in campo della coltura. Sebbene i suoi tentativi iniziali fossero infruttuosi, fornì materiali e spunti cruciali.
Glomerulo monogermo
Un glomerulo monogermo è una struttura (ad esempio, un frutto) che, per natura genetica, contiene un solo seme al suo interno. Il termine deriva dall’unione di “monogermo” (cioè con un solo seme) e “glomerulo” (un aggregato di elementi, come fiori o semi). I glomeruli monogermi sono le unità fondamentali della barbabietola da zucchero e la loro importanza risiede nel fatto che consentono una maggiore uniformità nella coltivazione, semplificando le operazioni di raccolta e ottenendo un prodotto più omogeneo e di migliore qualità per l’estrazione dello zucchero.
La monogermia genetica, oggi diffusa nel mondo, deriva indirettamente dagli studi del Munerati: la prima linea monogerme, selezionata negli USA, ha legami con materiali provenienti da Rovigo. Anche la resistenza alla rizomania, malattia virale che comprometteva gravemente le coltivazioni italiane fino agli anni ’80, è legata a varietà da lui studiate a partire dal 1915.
Tuttavia, il mondo bieticolo ricorda il nostro scienziato soprattutto per l’individuazione di linee resistenti alla malattia più devastante della barbabietola da zucchero, la Cercospora beticola.
Già nel 1925 disponeva di linee resistenti, ottenute incrociando la barbabietola coltivata con Beta vulgaris ssp. maritima. Queste linee furono inviate negli USA, dove migliorarono la resa in condizioni di malattia epidemica. Ancora oggi si considera questa una delle scoperte più rilevanti nel controllo genetico della cercospora.
Munerati fu, infine, determinante per l’avvio della produzione di seme italiano, sostenendo la messa a dimora dei portaseme in agosto e imponendo l’isolamento della coltura per evitare inquinamenti dovuti alla dispersione anemofila del polline. La sua visione permise di ridurre i costi e aumentare la qualità del seme italiano, tanto che ancora oggi la Pianura Padana è punto di riferimento mondiale per la riproduzione di semente di barbabietola da zucchero.
Nonostante il suo straordinario contributo, Munerati si sentì spesso incompreso. Nel 1951 arrivò però un importante riconoscimento da oltreoceano. Nell’ambito del piano Marshall di ricostruzione al termine della Seconda Guerra Mondiale, il Governo degli Stati Uniti dispose di costruire a Rovigo una nuova sede per la Stazione Sperimentale di Bieticoltura, quale ringraziamento per l’opera del Munerati per la bieticoltura statunitense. Tale sede è ancora oggi la sede del CREA, Centro di Ricerca cerealicoltura e Colture Industriali, nella città veneta. E, a distanza di decenni, la bieticoltura continua a beneficiare delle sue intuizioni pionieristiche. Figura centrale nella storia agronomica italiana e internazionale, Munerati resta un precursore indiscusso.

Primo Ricercatore, Sede CREA di Rovigo
Laurea in Scienze Agrarie, Diploma di specializzazione in Fitopatologia ed abilitazione Agronomo conseguite presso l’Università di Bologna. L’attività professionale indirizzata allo studio di tecniche diagnostiche per l’isolamento e l’identificazione di agenti patogeni su colture cerealicole e industriali con particolare interesse per le sementi.
#lafrase Albero: l’esplosione lentissima di un seme (Bruno Munari)

Professore associato – DAFNAE UNIPD