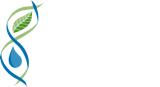Cereali e colture industriali: le radici dell’agricoltura italiana e il ruolo strategico della ricerca
In Italia, i cereali rappresentano la colonna portante della nostra agricoltura, sia per estensione delle superfici coltivate che per volumi produttivi. È un dato strutturale, confermato dalle statistiche e rafforzato dalla centralità che queste colture occupano nelle principali filiere agroalimentari del Paese.
Secondo le proiezioni 2025/2026 della Commissione Europea, la produzione cerealicola italiana nel 2025 è stimata in 13,5 milioni di tonnellate, su circa 2,8 milioni di ettari coltivati. Un dato che riflette l’importanza del comparto, ma che impone anche riflessioni profonde sul futuro del settore nel contesto di un mercato europeo e globale sempre più complesso. In particolare, l’Italia mantiene un ruolo di leadership nella produzione di grano duro, con una stima tra 4 e 4,5 milioni di tonnellate – in netta crescita rispetto ai 3,5 milioni dell’annata precedente – contribuendo in modo decisivo agli 8 milioni di tonnellate prodotti complessivamente nell’Unione Europea. Questa leadership si riflette nella filiera grano-pasta, simbolo del Made in Italy nel mondo: oltre 2,57 milioni di tonnellate di pasta esportate nel 2024, per un valore prossimo ai 4 miliardi di euro, con più del 60% della produzione destinata ai mercati esteri.
Ma non solo grano. Il mais nazionale resta un pilastro per le filiere zootecniche d’eccellenza, da cui derivano prodotti DOP e IGP di rilevanza internazionale, come formaggi e salumi, che nel 2024 hanno registrato una crescita del 10% in valore e in volume. L’Italia, inoltre, è il primo produttore europeo di riso, coltivato su oltre il 56% della superficie comunitaria, con una produzione di 1,4 milioni di tonnellate e un valore economico superiore ai 500 milioni di euro.
A fianco dei cereali, le colture industriali – come girasole e colza (per gli olii vegetali), soia e mais (mangimi), barbabietola da zucchero (zuccheri), lino e canapa (fibre), patata, pomodoro e legumi (prodotti surgelati, conservati e trasformati ) – svolgono un ruolo fondamentale, sia come destinazione per l’industria alimentare e non alimentare, sia come elemento strategico nelle rotazioni colturali. Negli ultimi anni, queste colture hanno mostrato una vivace dinamica innovativa, anche grazie all’introduzione di nuove specie e all’espansione di filiere emergenti, legate alla bioeconomia, all’alimentazione funzionale e agli impieghi energetici.
Tuttavia, il quadro non è privo di criticità. Dal 2012 al 2024, ad esempio, le superfici coltivate a mais si sono dimezzate. Le cause sono note: da un lato, l’impatto sempre più evidente del cambiamento climatico, che rende incerta la produttività; dall’altro, la stagnazione delle rese e la pressione sui prezzi, legata alla natura “commodity” di molte produzioni e alla forte concorrenza internazionale.
In tale contesto, soprattutto per le aziende di piccola e media dimensione, per restare sul mercato, è richiesta una gestione aziendale sempre più professionale, orientata all’uso delle tecnologie, alla pianificazione industriale e all’innovazione continua. Occorre, inoltre, rafforzare la qualità e la tracciabilità del prodotto nazionale, investire in strumenti di stabilizzazione del reddito, e promuovere i contratti di filiera.
Le colture industriali condividono le stesse criticità, aggravate dalla concorrenza estera e dalla volatilità dei prezzi. Eppure, per entrambe le filiere – cerealicola e industriale – si intravedono importanti opportunità: l’evoluzione dei consumi, la crescita della domanda per nuovi utilizzi (come biomasse, alimenti funzionali, ingredienti innovativi) e le nuove esigenze della sostenibilità stanno ridefinendo lo spazio competitivo.
È in questo scenario che il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali del CREA svolge un ruolo centrale. Forte di una lunga tradizione scientifica – erede delle storiche Stazioni Sperimentali che hanno contribuito all’autosufficienza alimentare del Paese – il Centro orienta oggi le proprie attività alla costruzione di soluzioni per aumentare le rese e la resilienza delle colture in un clima che cambia. L’approccio è integrato e multidisciplinare: genomica, miglioramento genetico, agronomia, patologia vegetale, tecnologie alimentari e chimica concorrono alla creazione di nuove varietà, più produttive, più resistenti, più sostenibili.
Attraverso l’impiego delle tecnologie più avanzate – come ad esempio l’intelligenza artificiale per l’analisi dei fenotipi digitali, la selezione genomica predittiva, e l’applicazione delle Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) – il Centro è impegnato nell’incrementare la conoscenza della più ampia diversità genetica disponibile nelle proprie collezioni e nello sviluppo di strumenti che rafforzano la competitività del settore sementiero nazionale e l’efficienza dei sistemi colturali. Queste innovazioni sono già operative su specie chiave come grano duro e riso, con l’obiettivo di ridurre l’uso di risorse e aumentare le rese, migliorare la qualità e mitigare gli impatti ambientali.
Il Centro interviene lungo tutta la filiera: dalla costituzione varietale (compresa quella per usi specifici o di nicchia, come la canapa medicinale o il lino da seme), allo sviluppo di nuove molecole con effetti benefici per la salute, fino all’implementazione di agrotecniche sostenibili, come l’agricoltura conservativa e la difesa non chimica.
Oggi più che mai, la ricerca pubblica è chiamata a essere un motore di cambiamento, in grado di anticipare le sfide e offrire soluzioni concrete. Il CREA è impegnato a sostenere la trasformazione del nostro sistema agroalimentare, affinché le produzioni cerealicole e industriali restino competitive, sostenibili e centrali nell’economia e nella cultura del nostro Paese.